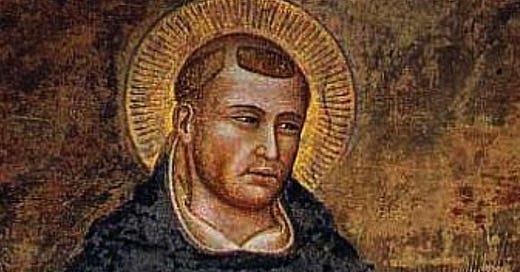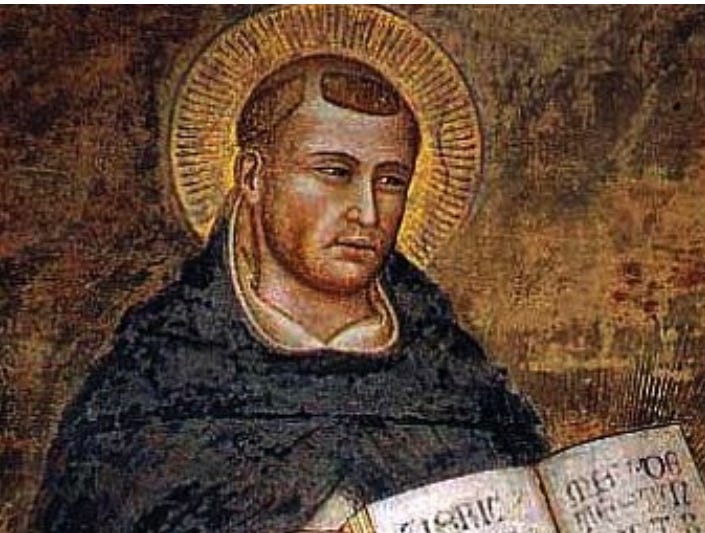Qualche tempo fa mi è capitato di leggere un ricordo di Mario Palmaro, scomparso alcuni anni fa per una grave malattia su Il Timone, e una frase da lui scritta mi ha colpito:
“Non è il Papa che crea la verità, il Papa ne è il custode, non è che una cosa è vera perché l’ha detta la Chiesa, ma la Chiesa la dice, perché è vera”.
Questa frase mi è venuta in mente quando riflettevo su cosa avrei dovuto dire su san Tommaso d’Aquino (1226-1274), astro sempre rifulgente del pensiero cattolico e, per questo, patrimonio di tutta l’umanità. Fino a non molto tempo fa, essere tomista era segno sicuro di essere cattolico che seguiva l’ortodossia, ciò che è giusto credere, più che l’ortoprassi, un vago “comportarsi bene” (ma secondo cosa?). Ma l’ortoprassi non ha senso se privata dell’ortodossia, perché il mio comportamento non sarà corretto se non verrà correttamente guidato. L’ortoprassi è quella che è alla base della nozione di “bene possibile”, per cui una cosa non è giusta o sbagliata ma può diventare giusta “a certe condizioni”. Guardate che questa nozione la troviamo impiegata dappertutto, anche nella liturgia, in cui spesso considerazioni che esulano completamente dalla stessa proteggono persone di buona volontà ma con una preparazione del tutto inadeguata.
Il pensiero del nostro umile frate domenicano, il tomismo, ha garantito un’argine alla deriva dell’intelligenza che bramava la celebrazione di se stessa (bisognerebbe rileggere il francese Marcel de Corte per un sano sviluppo di questo concetto) garantendo un ritorno alla verità delle cose. Si racconta che all’inizio delle sue conferenze san Tommaso mostrava una mela ai suoi spettatori e affermava: “questa è una mela. Se non siete d’accordo, potete uscire”. Cosa significava? Significava e significa che non ci può essere discorso che non parta dall’accettazione della verità delle cose per quello che sono. Ecco che allora la verità era da lui definita, sulla scia di una tradizione di pensiero non solo cristiano, adaequatio rei et intellectus, cioè l’intelletto che si adegua alla verità delle cose. Questo sano realismo ci protegge dal praticare una religione che si basa sui contorcimenti dell’intelletto su se stesso, ci permette proprio di dire cose vere perché sono vere in se stesse, non perché le diciamo noi.
Padre Enrico Zoffoli nel suo San Tommaso d’Aquino: un ritratto (2024, a cura di Aurelio Porfiri, Chorabooks) così descriveva l’eredità del grande pensatore:
“A quarantanove anni, Tommaso d’Aquino ci ha lasciati eredi di una tra le sintesi più originali e poderose del pensiero umano di tutti i tempi, e tale da articolarsi in una produzione letteraria che sbalordisce (...). La ricchezza delle fonti del suo pensiero è tanta che sarebbe incredibile, se non affiorasse continuamente dalle sue opere. L’Aquinate conosce benissimo (e ricorda persino a memoria) i principali tra i Padri della Chiesa greca e latina, come risulta anche dalla sua Catena aurea in Evangelia. La “selva selvaggia e aspra e forte” delle opere di s. Agostino gli è familiare. Si mostra informato di tutti gli scrittori e i documenti ecclesiastici, dalle origini ai suoi tempi. Domina l’intera letteratura greca e latina, dagli storici ai naturalisti, dai poeti ai filosofi e ai giuristi...Nel campo della bibliografia aristotelica non teme rivali, conoscendo i commentari dello Stagirita, antichi e contemporanei, arabi, ebrei, cristiani. Non si esagera se lo si ritiene l’erede più intelligente dell’intera cultura antica dell’Occidente....”.
Dicevamo del realismo di san Tommaso:
“È per merito del suo realismo che egli apre la via che mena alla fede nella conquista di quei motivi di credibilità che ne fanno il più accorto e felice superamento della ragione...” (E. Zoffoli, op. cit.).
Tommaso ci tiene ancorati al mondo proprio per superarlo in una sintesi più alta e ci insegna che il Cristianesimo non rifiuta la realtà, come era proprio di alcune tendenze eretiche in seno allo stesso Cristianesimo o come è caratteristica di alcune religioni orientali, ma la penetra, comprende e accetta e solo dopo questo, la supera per una Realtà più grande.
Un tomista profondo come Antonio Livi, vede in questo modo il Tomismo:
“L’Aquinate, a parte la grandezza e l’originalità della sua speculazione, è anche autore di una sintesi teoretica in cui convergono coerentemente Platone, Aristotele, il neoplatonismo, il pensiero patristico, la filosofia araba e quella giudaica: la filosofia tommasiana si potrà dunque prestarsi agevolmente a un discorso di confronto e collegamento tra il pensiero antico e quello medioevale, e poi tra quello medioevale e quello moderno. Caratteristica della filosofia tomista è la perfetta coerenza di elementi gnoseologici tipici dell’empirismo con quelli che sembrerebbero caratterizzare l’intellettualismo. In realtà, bisogna sempre ricordare che san Tommaso ha una costante attenzione all’unità del sistema della verità, dell’esperienza, che significa unità tra percezione sensibile e conoscenza intellettuale, tra prima operatio intellectus e giudizio, tra intellectus e ratio: unità, certamente, nella distinzione, che analiticamente viene precisata dalla gnoseologia tomista, ma mai giunge al punto da attribuire valore autonomo a uno dei singoli momenti della conoscenza” (2007, Senso comune e logica aletica).
Troppo grande sarebbe lo spettro del pensiero di Tommaso per voler dare anche solo un cenno di questo pensiero con pretesa di completezza. Quindi ci si deve accontentare di isolare questo aspetto del realismo che mi sembra però a fondamento di tutto il resto.
Nell’Enciclica Aeterni Patris (1879), il papa Leone XIII così identificava il contributo di Tommaso d’Aquino alla tradizione di pensiero cristiana:
“Per la verità, sopra tutti i Dottori Scolastici, emerge come duce e maestro San Tommaso d’Aquino, il quale, come avverte il cardinale Gaetano, "perché tenne in somma venerazione gli antichi sacri dottori, per questo ebbe in sorte, in certo qual modo, l’intelligenza di tutti". Le loro dottrine, come membra dello stesso corpo sparse qua e là, raccolse Tommaso e ne compose un tutto; le dispose con ordine meraviglioso, e le accrebbe con grandi aggiunte, così da meritare di essere stimato singolare presidio ed onore della Chiesa Cattolica. Egli, d’ingegno docile ed acuto, di memoria facile e tenace, di vita integerrima, amante unicamente della verità, ricchissimo della divina e della umana scienza a guisa di sole riscaldò il mondo con il calore delle sue virtù, e lo riempì dello splendore della sua dottrina. Non esiste settore della filosofia che egli non abbia acutamente e solidamente trattato, perché egli disputò delle leggi della dialettica, di Dio e delle sostanze incorporee, dell’uomo e delle altre cose sensibili, degli atti umani e dei loro principi, in modo che in lui non rimane da desiderare né una copiosa messe di questioni, né un conveniente ordinamento di parti, né un metodo eccellente di procedere, né una fermezza di principi o una forza di argomenti, né una limpidezza o proprietà del dire, né facilità di spiegare qualunque più astrusa materia. A questo si aggiunge ancora che l’angelico Dottore speculò le conclusioni filosofiche nelle intime ragioni delle cose e nei principi universalissimi, che nel loro seno racchiudono i semi di verità pressoché infinite, e che a tempo opportuno sarebbero poi stati fatti germogliare con abbondantissimo frutto dai successivi maestri. Avendo adoperato tale modo di filosofare anche nel confutare gli errori, egli ottenne così di avere debellato da solo tutti gli errori dei tempi passati e di avere fornito potentissime armi per mettere in rotta coloro che con perpetuo avvicendarsi sarebbero sorti dopo di lui. Inoltre egli distinse accuratamente, come si conviene, la ragione dalla fede; ma stringendo l’una e l’altra in amichevole consorzio, di ambedue conservò interi i diritti, e intatta la dignità, in modo che la ragione, portata al sommo della sua grandezza sulle ali di San Tommaso, quasi dispera di salire più alto; e la fede difficilmente può ripromettersi dalla ragione aiuti maggiori e più potenti di quelli che ormai ha ottenuto grazie a San Tommaso. Per queste ragioni, specialmente nelle passate età, uomini dottissimi e celebratissimi per dottrina teologica e filosofica, ricercati con somma cura gl’immortali volumi di Tommaso, si diedero tutti all’angelica sapienza di lui, non tanto per averne ornamento e cultura, quanto per esserne sostanzialmente nutriti. È cosa nota che quasi tutti i fondatori e i legislatori degli Ordini religiosi hanno ingiunto ai loro seguaci di studiare le dottrine di San Tommaso, e di attenersi ad esse con la maggiore fedeltà, provvedendo che a nessuno sia lecito impunemente dipartirsi anche di poco dalle orme di tanto Dottore. Per non dire dell’Ordine domenicano, il quale come per suo proprio diritto si onora di questo sommo maestro, sono tenuti da tale legge anche i Benedettini, i Carmelitani, gli Agostiniani, la Compagnia di Gesù e parecchi altri, come attestano i loro specifici statuti”.
Purtroppo non è raro oggi assistere ad un rifiuto del tomismo anche in venerabili congregazioni religiose in nome dell’adesione ad un pensiero moderno che non è solo un allontanamento dal tomismo ma, forse proprio per questo allontanamento, anche un rifiuto del procedere naturale della ragione. San Pio X affermava nella Pascendi (1907) che un chiaro indizio dell’avanzare del modernismo è nel rifiuto della scolastica, quindi del pensiero di Tommaso che ne è il cuore. Ma al tomismo dovrebbero ricorrere tutti coloro che hanno a cuore l’uso della ragione. Un tomista come il cardinale Dino Staffa poteva affermare:
“La filosofia tomista, pur essendo prescritta dalla Chiesa, non cessa di essere filosofia, opera cioè esclusiva della ragione. L’autorità che l’impone non intende sostituirsi alla dimostrazione e all’evidenza instrinseca delle sue conclusioni” (1989, Il Tomismo è vivo).
Insomma, san Tommaso d’Aquino appartiene all’umanità proprio perché parte dai dati di fatto della realtà, un aderenza alle esigenze di pensiero naturali che nessuna razionalità, se non vuole suicidarsi, può rifiutare. Purtroppo anche nella Chiesa, il non rispetto della verità sostituita dalla nozione relativista del “bene possibile” si è fatta strada in molte, troppe menti.